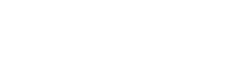Il binomio carcere e diritti risulta sempre un boccone amaro da digerire per l’opinione pubblica.
Del resto perché mai dovrebbe essere meritevole di diritti chi con le proprie azioni, più o meno consapevolmente, ha privato qualcun altro di quegli stessi diritti?
È qui che entra in gioco la differenza tra la vendetta privata e lo Stato che si fa terzo, imparziale e garante della dignità umana.
Quando un soggetto entra in carcere, sia per effetto di una misura cautelare (e quindi, prima che sia effettivamente provata la sua responsabilità penale) sia per scontare una pena definitiva (e quindi al termine del processo a cui è stato sottoposto) lo Stato diventa il suo custode: il suo ruolo dunque è quello di garantire che venga rispettata la sua persona e venga perseguito il fine rieducativo della pena, così come indicato dall’art. 27 della nostra Costituzione.
Il terzo comma del sopracitato articolo recita infatti che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”: quindi l’ingresso nel circuito penitenziario non dovrebbe rappresentare una sorta di “parcheggio” per il reo, ma un’opportunità di riflessione e di ripartenza.
Spesso però non è così e il carcere diventa un contenitore traboccante di disagio sociale, violenze, malesseri e criminalità: tutto ciò non rimane all’interno delle celle chiuse a doppia mandata, come vorrebbero gli animi sicuritari, ma viene restituito alla società.
In che modo?
Un individuo detenuto una volta scontata la pena inflittagli tornerà libero: e come potrà essere il ritorno in società di colui che per mesi o anni ha convissuto in un ambiente criminogeno?
E allora sarebbe opportuno ripensare alla funzione del carcere come extrema ratio, all’utilizzo dei percorsi di mediazione e, ultimo ma non ultimo, ad una sensibilizzazione della collettività su queste delicate tematiche.
Dott.ssa Silvia Galimberti